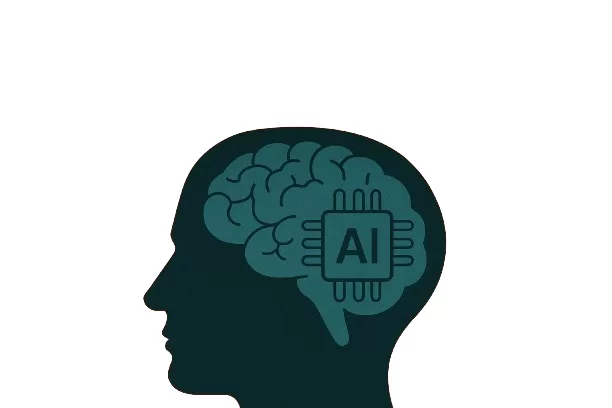Ce lo siamo già chiesti: era il 2010 quando Nicholas Carr, con una domanda provocatoria scriveva sul The Atlantic: “Google ci rende stupidi?”. Ne nacque un libro illuminante ma in Italia, a parte un dibattito di nicchia, se ne parlò poco, rilanciando quel dubbio tra il serio e il tragico: l’ipertrofia dell’informazione digitale ci stava rubando concentrazione, profondità, capacità di pensiero lungo. Poi, come spesso accade da noi, il dibattito si polarizzò rapidamente e le avvisaglie degli studiosi vennero subito “taggate” come apocalittiche. Nel frattempo sono arrivati gli smartphone tutto-fare, l’infodemia permanente e i social dominanti, i server colmi di idiozie e l’inondazione di odio e fake news, fino agli odierni video da trenta secondi (quando va bene) e alla dittatura dell’algoritmo.
Oggi, come in un copione già scritto, l’interrogativo ritorna accompagnato però da un sospetto più radicale. Perché non si tratta più soltanto di cercare e fruire informazioni, ma di produrre contenuti e di scrivere indipendentemente dal fatto che si abbia o meno cognizione di causa. Ed è qui che scatta il cortocircuito: non sai, ma devi esserci in rete. Non ti serve sapere, analizzare e approfondire; basta lasciare un segno nella rete, purché sia, magari delegando il contenuto a un’intelligenza artificiale. Come sta già accadendo – ce lo racconta la cronaca – con valutazioni scolastiche, tesi universitarie e produzioni in ambito lavorativo. Di conseguenza ci si chiede se stiamo diventando meno lucidi, meno autonomi e vigili. Ma forse la domanda è già superata, perché il rischio non è tanto che l’intelligenza artificiale ci renda stupidi: il rischio vero è che ci addestri a esserlo, un giorno dopo l’altro, parola dopo parola.
Immagino l’obiezione dei lettori: la tua è inquisizione oscurantista contro le nuove tecnologie? No, mi limito – da vero boomer – a leggere e studiare uno studio recente e tutt’altro che marginale, condotto dal MIT Media Lab sotto la guida della ricercatrice Natalia Kosmyna. Il titolo, già di per sé eloquente, suona come un avvertimento: “Your brain on ChatGPT: cognitive debt accumulation from using an AI assistant for writing tasks”. Il cuore dell’indagine è semplice: capire cosa accade al nostro cervello mentre scrive, e cosa cambia se, a scrivere, ci aiuta un’intelligenza artificiale.
Il campione è stato suddiviso in tre gruppi: il primo ha scritto affidandosi unicamente alle proprie risorse mentali, senza alcun accesso a schermi, app o connessione; il secondo ha potuto utilizzare Google; il terzo ha lavorato con il supporto di ChatGPT. Tutti i partecipanti sono stati collegati a un elettroencefalografo per misurare l’attività cerebrale durante la redazione di tre testi, distribuiti nel tempo. Ed è qui che arrivano i dati. Rispetto al gruppo “brain only”, chi ha usato Google ha registrato una riduzione della connettività cerebrale compresa tra il 34% e il 48%; con ChatGPT, la riduzione ha toccato punte ancora più basse: fino al 55% in meno. Più consistente è il supporto digitale, più si indebolisce l’attivazione del cervello. E non è solo una questione di quantità: cambiano anche le aree coinvolte. Chi ha scritto senza aiuti ha attivato le zone deputate alla creatività, all’elaborazione semantica e all’automonitoraggio; chi ha usato Google ha sollecitato prevalentemente la corteccia occipitale e visiva, necessaria ad assimilare stimoli esterni; chi ha scritto con ChatGPT ha ridotto la propria attività a meccanismi quasi automatici, di pura risposta.
Anche i risultati dei testi sono stati rivelatori. I contributi del gruppo “brain only” si sono rivelati più vari, personali, con tratti stilistici riconoscibili; quelli generati con l’AI, invece, sono risultati omogenei, prevedibili, strutturalmente molto simili tra loro. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stata la perdita di consapevolezza: l’83% dei partecipanti che aveva scritto con ChatGPT non è stato in grado di ricordare nemmeno una frase del proprio testo. È come se l’elaborazione non fosse mai passata per la coscienza: il contenuto non era stato assimilato, né riconosciuto. Non era più “loro”.
E la parte forse più interessante dello studio è arrivata dopo. Nella quarta e ultima sessione, i gruppi si sono invertiti: chi aveva sempre scritto con l’AI è stato chiamato a produrre un testo senza alcun supporto; chi aveva lavorato in autonomia ha potuto usare Chat GPT. Il risultato è stato netto: il gruppo “assistito” ha mostrato difficoltà evidenti nel riattivare i propri schemi cognitivi, come se avesse disimparato a pensare da solo. Solo due persone su dieci sono riuscite a richiamare con precisione contenuti trattati in precedenza. Il cervello, disallenato, è sembrato meno capace di ideare, rielaborare, costruire. Kosmyna ha definito questo fenomeno “debito cognitivo”: una forma di pigrizia mentale acquisita.
L’intelligenza artificiale, insomma, non cancella la nostra capacità di pensiero ma la spegne lentamente se glielo permettiamo. Al contrario, chi aveva allenato una riflessione autonoma nelle fasi precedenti è riuscito a usare ChatGPT come uno strumento, traendone vantaggio senza rinunciare al controllo. Anche l’elettroencefalogramma lo ha confermato: nei “nativi autonomi” l’attività cerebrale è rimasta intensa, anche con l’ausilio dell’AI. Non perché l’intelligenza artificiale sia buona o cattiva: ma perché una mente già attiva sa dominare lo strumento, mentre una mente passiva finisce per esserne risucchiata.
Le implicazioni sono ampie e travalicano l’ambito scolastico. Se ci abituiamo a non pensare, a non vigilare su ciò che diciamo o scriviamo, il danno non si limita alla qualità della scrittura, ma si estende alla qualità della cittadinanza. Una comunità che rinuncia a possedere le proprie idee, che replica testi che non riconosce, che si affida al giudizio altrui senza esercitare il proprio, è una comunità più fragile. Più governabile. Più esposta alla propaganda.
Lo studio del MIT non è un atto d’accusa contro la tecnologia: è un invito alla responsabilità. L’intelligenza artificiale può essere uno strumento prezioso, ma solo dopo aver maturato un pensiero critico, personale, profondo. Chi non ha mai imparato a pensare da solo, con l’AI non diventa più intelligente: diventa solo più veloce nel ripetere ciò che altri hanno deciso per lui.
Per questo, oggi, più che della stupidità, dovremmo preoccuparci degli addestrati. Addestrati a riprodurre, ad assentire acriticamente e a non chiedere.
Addestrati alla stupidità. E stiamo imparando in fretta.