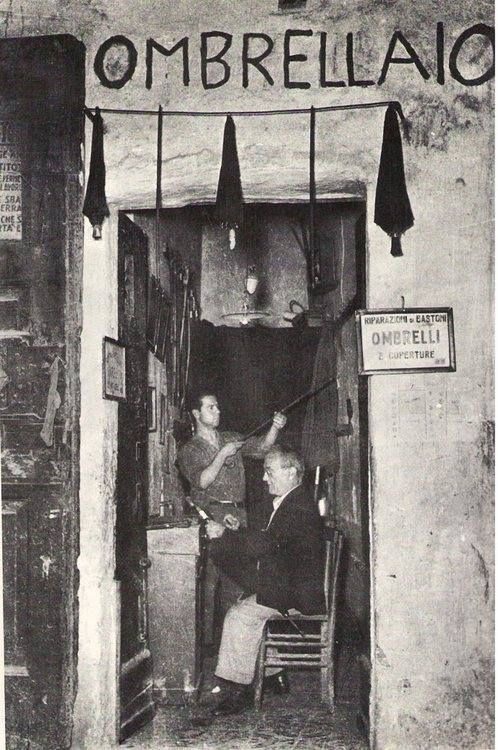Nuovo è una parola sempre vecchia che in contesto socioeconomico sbuca ogni volta che la realtà cambia e si cerca di adattare le sue nuove forme a impalcature vecchie. Oggi se ne riparla dopo la crisi pandemica, per capire cosa abbiamo – da etimo – setacciato come utile da ciò che non serve. Cosa abbiamo setacciato di quell’impossibile divenuto possibile? Di angusti spazi in sovraffollate città percorsi in tempi frenetici, improvvisamente allargati in paesaggi bucolici in un tempo dilatato? Di assenza trasformata in diversa presenza, o del pieno che diventa vuoto e vuoto non è? La pandemia è l’occasione, il tema sempre attuale. Qui parlerò di nuove tecnologie e nuovi lavori, spesso in relazione tra loro. Quanto conta una nuova tecnologia (digitale o analogica) per fare un nuovo lavoro? Quale intelligenza fa fiorire novità da rigide impalcature senza che ne vengano soffocate?
Le nuove tecnologie hanno spesso l’effetto di ridurre il tempo e allargare lo spazio (dispositivi sempre più veloci in molte operazioni automatiche e artificialmente intelligenti) oppure personalizzare un servizio altrimenti standardizzato. Complessivamente, ci liberano tempo e spazio aumentando velocità e capillarità. Magnifico. Per farne cosa? Di solito ulteriore velocità e capillarità, pandemia insegna. Ma la velocità è uno strano concetto in fisica e nella vita. Misura quanti passi ogni secondo, ma anche in che direzione. Curvare stretto in una nuova traiettoria è un (altro) modo per esplorare paesaggi nuovi, che può tenere insieme lentezza di passi e accelerazione. Eppure non basta. La prima lavastoviglie di Josephine Cochrane o lavatrice di Margaret Colvin hanno curvato le traiettorie delle donne ma non hanno reso il lavoro domestico nuovo o di maggior valore. Ma forse il progresso scientifico e tecnologico può adeguare un lavoro vecchio a tempi nuovi? Faccio un lavoro vecchio e nuovo di millemila anni: cerco e ricerco, insegno e dissemino scienza – le tre missioni di una docente universitaria – fisica e tecnologie quantistiche in particolare. Come ci sono arrivata? Da piccola correvo scalza nei torrenti della Magna Grecia, osservavo le stelle, giocavo a pallone, suonavo strumenti, fondavo associazioni e pensavo che la fisica fosse la poesia della matematica. Così mi sono innamorata del potere trasformativo del pensiero scientifico a connettere realtà e astrazione attraverso la perfezione dei suoi errori, e ogni angolo di mente attraverso i linguaggi della creatività, della matematica e degli esperimenti; e della scienza che genera tecnologie che poi scrivono la quotidianità delle persone. Oggi so che mi sono innamorata del mondo della scienza che potrà svelare i grandi misteri dell’umanità, non per caso una tessitura interdisciplinare, che ai rigidi incroci di quelle impalcature cuce ambienti di ricerca complessi per dimensioni, diversità, e dinamiche di funzionamento.
Per insegnare una ricerca così mutevole devo innovare metodi e programmi per non dilatare il tempo di formazione con la quantità dei prodotti della ricerca o preparare studenti al passato anziché al futuro: quanto più spesso accade a scuola, dove le due rivoluzioni scientifiche del ‘900 – meccanica quantistica e relatività – non hanno spazio adeguato, né lo ha la rivoluzione quantistica del nuovo millennio. Infine, per divulgare con rigore la scienza presso un pubblico senza le necessarie alfabetizzazioni, devo creare strumenti compensativi di quei tre linguaggi che non per caso spesso attingono ad arte e giochi interattivi: per poter curiosare tra le increspature più interessanti – quelle alla periferia della conoscenza sia di chi fa ricerca che di chi ne vorrebbe coglierne l’impatto nel proprio quotidiano. Insomma, allo sguardo di quella bambina scalza faccio continuamente un nuovo lavoro. Il prezzo è alto: il continuo disagio di trovare un agio tra le impalcature dell’accademia. Gli spazi cattedratici di aule universitarie, l’apnea di tempi cronologici che divorano quelli opportuni, la divisione in discipline e dipartimenti stagni, il rimbombo di spazi sempre da riempire, le barocche alchimie dei sistemi di valutazione dove – con le parole di Szymborska in “Scrivere un curriculum” – conta “meglio il numero di scarpa, che non dove va colui per cui ti scambiano”.
Come il mio, tanti lavori vecchi possono diventare sempre nuovi. Ma non per decreto. È la nostra presenza in ciò che facciamo e nelle strade che apriamo a dare nuova forma, riformare il lavoro. In questo, il binomio donne e nuovi lavori è estremamente interessante. Per noi la presenza autentica è una condizione di esistenza in vita: senza, come diciamo alla scuola Labodif, viviamo come controfigure che si adattano, minuziosamente perfezionandosi per non fallire, o si ribellano, come Erinni furiose, alla misura delle vecchie impalcature patriarcali. In ogni caso, in quel disagio è il nostro senso di inadeguatezza e la misura del nostro essere noi. Che può fare una politica che sostenga quel processo di riforma? Non velocizzare, ma cambiare traiettorie. E apprendere dall’intelligenza delle donne come rinnovare lavori vecchi e creare dal nulla lavori nuovi: è comunque una questione di una diversa misura.