Un volume da non perdere
La nozione di autorità: nell’opera di Alexandre Kojève, il defunto è identità collettiva latamente politica e ologramma
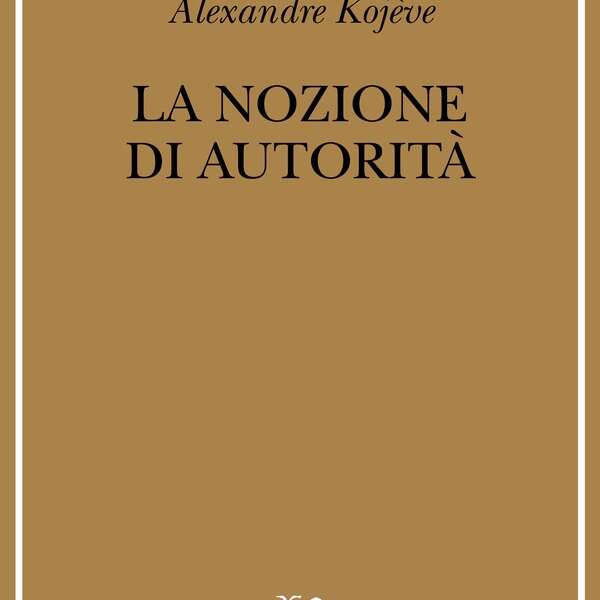
In un passaggio del suo ‘La nozione di autorità’, Alexandre Kojève trasfigura la carica simbolica del defunto, elevata all’assoluto del Morto, come soggetto incriticabile e come feticcio strumentale per la affermazione dell’autorità. Dal punto lontano e metafisico del cimitero, l’essenza ormai immateriale di un soggetto scomparso assume le vesti scure dell’arma dialettica perfetta: la tragica aura che circonda chi muore, la paura connessa alla morte, diventano elementi per affermare, o consolidare, l’espansione del principio di autorità. In fondo, alcuni anni dopo Emil Cioran ne ‘L’inconveniente di essere nati’ avrebbe santificato e lodato la morte come successo per chiunque in vita non abbia avuto alcun riconoscimento.
Sempre più spesso ascoltando le litanie funebri – sotto forma di articoli giornalistici o di orazioni – ciò che colpisce è la scomparsa totale, fagocitata da un dispositivo collettivizzante, della persona venuta a mancare e l’utilizzo meccanizzato della figura di chi si commemora per portare avanti polemiche, autocelebrazioni e soprattutto una qualche agenda politico-intellettualistica che facendo sponda sulla morte ambisce alla incriticabilità. E Kojève oltre alla incriticabilità tendeva a ricollegare alla figura ‘assolutizzata’ del defunto l’esercizio di un potere del tutto privo di responsabilità: essendo scomparso dalla linea d’orizzonte dello spazio fisico e della realtà, il defunto è essenza spettrale che non ha necessità alcuna di responsabilità. E chi se ne serve, si nasconde dietro il suo sudario, dietro la sua foto, dietro il suo nome. In questo senso, il defunto è identità collettiva latamente politica e ologramma. Una copia della persona non più presente, innervata dalle richieste, dalle opinioni, dalle idiosincrasie di altri soggetti, un rigoglio di argilla, un elementale modellato con le sembianze del defunto ma nutrito dall’ego di chi rimane.
Negli anni sessanta Arnold Gehlen notò quello che potrebbe essere definito il cardine di questo utilizzo strumentale della morte: l’espunzione del defunto e della sua fine, in senso storico, dal palcoscenico della società. Il pudore e il timore che circondano la morte l’hanno resa fumettistica, oleografica, proprio perché non riusciremmo a confrontarci con la sua vera, nera essenza. Sarebbe come fissare la luce malata di una eclissi e rimanerne accecati. Per questo, avvertiamo la necessità di addolcirne il peso.
Così, le articolazioni del potere, istituzionale o intellettuale che questo poi in concreto sia, hanno compreso come e quanto un uso strumentale della memoria, del sole oscuro rappresentato dal gelo della morte, possa divenire marchingegno potentissimo e senza pari per situarsi, proprio come il morto, fuori dal campo della dialettica culturale, politica, sociale. Non si parla più del defunto, ma si parla attraverso il defunto. Come una tavola ouija, la figura del morto è interfaccia mediante cui veicolare un messaggio che con il morto, con la sua personalità, con la sua identità, non ha più alcun collegamento – diventa così impossibile dire dove finisca lo spirito del morto e dove invece inizi l’egolatria di chi se ne fa medium.
Questo utilizzo del defunto sembra quasi richiamare, fatte le dovute contestualizzazioni, ciò che Bruno Latour ha definito ‘fatticci’, crasi significativa tra fatti e feticci. “Saggezza del passare, come ciò che permette il transito dalla fabbricazione alla realtà”; lo scomparso è instrumentum regni, autoaffermazione fabbricata, quasi industriale, di un flusso di informazioni e di comunicazione che nel morto afferma soltanto un soggetto altro che con il morto non c’entra nulla.
Narcisismo del commiato, e nel commiato, e non stupisce che la stessa religione contemporanea si sia, con alcuni suoi esponenti, accodata a questa figura del potere, in quell’autentico rituale di ego fioriti che sono usi darsi convegno non per celebrare uno scomparso ma soltanto loro stessi. Tutti a cantar lodi davanti uno specchio funereo. Tutti incriticabili, per interposta persona.
© Riproduzione riservata






