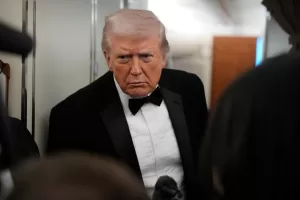La semplificazione morale
La viralità di Francesca Albanese, come è nato il brand narrativo che fa volare l’algoritmo: la tragedia, Israele cattivo e silenzio su Hamas

A partire dal 7 ottobre 2023, Francesca Albanese ha utilizzato i social media non solo come un megafono per le sue denunce, ma anche come architettura strategica per costruire la sua identità pubblica. Non è solo una giurista, né solo un’attivista, né solo una funzionaria ONU; è un ibrido attentamente calibrato: la coraggiosa paladina della causa palestinese contro l’indifferenza globale.
Esaminando l’utilizzo dei suoi canali social, ciò che colpisce non è solo la forza delle affermazioni, ma anche la cura con cui sono formulate e diffuse. La Albanese si presenta come un esempio quasi didattico di gestione scientifica della comunicazione digitale, orchestrata con una coerenza terminologica e visiva che ricorda più una macchina da guerra comunicativa che una voce spontanea della società civile. Le ricerche su di lei di Google Trend iniziano a salire a maggio 2025, con il rilancio del rapporto sul “genocidio israeliano”, ed esplodono dopo le sanzioni USA. Un’ascesa che procede di pari passo con una progressiva radicalizzazione del linguaggio: nei giorni immediatamente successivi al 7 ottobre, sembrava mantenere una certa equidistanza, includendo negli interventi condanne degli attacchi di Hamas; ma questa postura è stata presto accantonata in favore di una narrazione sempre più netta, in cui la colpa israeliana è diventata esclusiva, totalizzante e indiscutibile. Più il tono si irrigidiva, più la popolarità cresceva.
I contenuti fissati sul suo profilo TikTok non sono video occasionali o improvvisati: sono il manifesto narrativo del suo pensiero. Così quelli diffusi su Instagram: montaggi brevi ma intensi, “tappetini” musicali carichi di pathos, tagli calibrati, sottotitoli multilingue e un uso sapiente della luce e del bianco e nero, che suggeriscono gravità, lutto e urgenza. Anche su X – piattaforma dove si mostra sorprendentemente prolifica – i concetti chiave si ripetono con insistenza rituale, tornando in ogni contenuto con variazioni minime ma carica simbolica crescente: il genocidio – non più un tema da discutere, ma un dato di fatto – si affianca alla “pulizia etnica”, alla crisi umanitaria come strumento deliberato di guerra e alla rappresentazione della Palestina come una “scena del crimine” globale. A questo si unisce un’idea di corresponsabilità che va oltre i governi e si rivolge alle aziende e ai consumatori: è fondamentale, insiste, fermare non solo la vendita di armi, ma qualsiasi relazione commerciale con Israele.
Più indignazione, più condivisioni
Ogni video è un esercizio di influencing semantico ben congegnato: parole come “resistenza”, “impunità” e “complicità” vengono caricate di significati morali, mai esplicitati ma evocati con una precisione chirurgica. È una strategia. Che funziona perché intercetta emozioni forti — indignazione, rabbia, senso d’ingiustizia — e le orchestra gettandole in pasto agli algoritmi. Perché l’utente medio non cerca narrazioni nuove, ma conferme alle proprie opinioni, creando così un circolo vizioso: la domanda di contenuti polarizzati genera contenuti come quelli della Albanese, e l’offerta radicalizza ulteriormente la domanda. Una logica perfettamente funzionale al mercato dell’attenzione. Più indignazione, più condivisioni.
Il silenzio strategico su Hamas
Non è semplicemente un caso di framing ideologico. È una costruzione narrativa integrale, rigida: una monocultura semantica dove gli altri conflitti non esistono. C’è un solo attore negativo – Israele – un solo popolo vittima – i palestinesi – e un solo dovere etico: denunciare senza riserve. E a rendere ancora più efficace questa architettura discorsiva è una doppia codifica comunicativa, centrale nel successo mediatico di Francesca Albanese: da un lato parla all’opinione pubblica occidentale con il linguaggio dei diritti umani e dei trattati internazionali; dall’altro si rivolge implicitamente – ma con evidenti ammiccamenti – a un pubblico mediorientale che riconosce nella sua retorica elementi familiari: il diritto alla “resistenza”, il silenzio strategico su Hamas, l’assenza di qualunque condanna esplicita del terrorismo. La sua neutralità apparente le consente di muoversi su due binari senza mai entrare in collisione: voce terzista e tecnocratica in Occidente, voce complice e solidale nel Sud globale. Non appartiene a nessun partito, a nessun governo, a nessuna diplomazia – e proprio per questo diventa inafferrabile.
Cosa c’è dietro la sua viralità
Ed è proprio qui che sorge una domanda cruciale: come può una funzionaria dell’ONU, con un passato da consulente e una visibilità quasi inesistente fino al 2022, diventare in pochi mesi la figura più discussa e virale della questione israelo-palestinese? La risposta risiede proprio in questa combinazione perfetta di fattori narrativi, tecnologici e culturali: una narrazione semplice ma emotivamente coinvolgente – ben sostenuta da centinaia di volenterosi account “sponsor” -, un algoritmo social che favorisce contrapposizione e polarizzazione, un linguaggio senza filtri e un posizionamento strategico tra attivismo e istituzione, tra indignazione e credibilità tecnica. Francesca Albanese non è un caso isolato. È il risultato ideale della comunicazione moderna. Un brand narrativo nato nella tragedia e scolpito nella semplificazione morale. Un algoritmo che prende vita, che, come ogni brand di successo, è quasi impossibile da smontare, ma incredibilmente facile da condividere.
È proprio qui che sorge la domanda cruciale: come può una funzionaria, con un passato da consulente e una visibilità inesistente fino al 2022, diventare in pochi mesi la figura più virale della questione israelo-palestinese?
© Riproduzione riservata