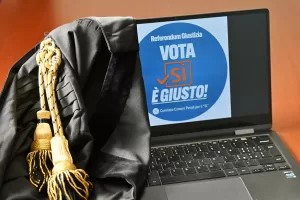Chicco, Claudio e il Pci
Quando il crollo del Muro di Berlino segnò per il Partito Comunista Italiano l’ora della resa dei conti
12 – Con il 1989 a sgretolarsi sono anche le appartenenze e gli unanimismi di facciata. Il mito della diversità della sinistra deve fare i conti con il mondo che cambia. Ma non tutti sono pronti a seguire la svolta e ad accogliere una nuova visione politica

Caro Claudio,
una delle pagine più drammatiche, ma anche più importanti, che abbiamo vissuto insieme fu certamente quella della fine del PCI. E sì, perché anche il grande partito ad un certo punto ebbe la sua fine. I fatti sono noti, li ripercorro solo brevemente. L’anno fatidico è il 1989, uno dei momenti cruciali della seconda metà del secolo scorso. Cade il muro di Berlino e tutto cambia. Nel 1991 addirittura Gorbaciov decreterà anche la fine dell’URSS. Non voglio parlare dei fatti storici, che sono piuttosto noti, ma di quella tragedia umana che per molti rappresentò la fine del nostro partitone. Verso la fine di quell’anno Occhetto, diventato segretario del PCI al posto di Natta nel 1988, va alla Bolognina – due giorni prima era caduto il muro – nella sezione del partito in quel quartiere di Bologna e annuncia che ci vuole un cambiamento profondo e radicale. Alla domanda di alcuni giornalisti che chiedono se anche il nome del partito deve cambiare, Occhetto risponde: “Ho detto che tutto può cambiare, nulla è escluso”.
Per me e per molti fu una dichiarazione liberatoria. Non avevamo mai amato la Russia comunista e stavamo nel PCI per il compromesso storico, la battaglia per il divorzio e i diritti, per il Berlinguer che si era detto più sicuro sotto l’ombrello della NATO e aveva affermato di fronte ai bonzi di tutti i partiti comunisti del mondo che la democrazia e il pluralismo erano valori universali. Ma a molti scattò dentro un’emozione quasi primitiva, un rifiuto netto ad abbandonare una storia e un’identità che avevano segnato la loro vita e il loro immaginario. E improvvisamente ci scoprimmo, avendo militato a lungo nello stesso partito, profondamente diversi gli uni dagli altri. Come se avessimo vissuto per anni dentro un grande equivoco, facendo finta di pensarla più o meno allo stesso modo.
Ricordo perfettamente il Comitato Centrale in cui venne poi deciso di tenere un Congresso straordinario per assumere la decisione del cambiamento. Affollato come mai era stato, molti in piedi, stavi fianco a fianco con amici improvvisamente diventati potenziali avversari, e spiavi i loro occhi cercando di indovinare da che parte sarebbero stati. Claudio Petruccioli mi ha raccontato un passaggio molto significativo. Nel suo intervento disse che in fondo da tempo il PCI non era più un partito comunista nel senso stretto del termine, ma piuttosto un partito socialdemocratico. Verità evidente e lapalissiana. Fu interrotto platealmente da Natta che dalla platea gli gridò “parla per te”. Al che Petruccioli gli ricordò le molte conversazioni fra di loro in cui avevano pienamente concordato su questo punto di vista. Ma non ci fu niente da fare. Mi sono domandato molte volte perché tante persone ragionevoli – Natta per esempio non era certo un incendiario – non fossero disposte a seguire Occhetto, in quella che era evidentemente una svolta necessaria e sicuramente tardiva. Non erano in ballo visioni programmatiche diverse o alleanze da discutere.
Erano in ballo semplicemente l’identità e le emozioni. Quello stato d’animo che Bertinotti riassunse in una frase: “I comunisti come i cristiani stanno in questo mondo, ma non appartengono a questo mondo”. Il che, per gente che vuole fare politica e cercare tramite essa di migliorare un poco il mondo, è un’affermazione paradossale. Purtroppo questa tendenza di molta gente di sinistra a privilegiare la loro “diversità”, parola chiave nell’immaginario del vecchio PCI, rispetto alla capacità di leggere il mondo per quello che effettivamente è e farci i conti in modo razionale non mi pare finita. E porta la sinistra inevitabilmente verso la marginalità. Ad essere percepita come “estranea”. Forse è quel che desidera. Un placebo, anziché una medicina.
***
Caro Chicco,
nel fatidico 1989 ero segretario regionale del partito in Basilicata, in qualche modo considerato come facente parte del gruppo dirigente nazionale del partito, anche se a capo di una piccola realtà territoriale. Per questo ero spesso coinvolto nelle riunioni della direzione nazionale, pur non facendone parte: dal momento in cui, nel giugno del 1988, Occhetto fu eletto segretario, con i suoi più stretti collaboratori (Petruccioli, Fassino, Veltroni) tendeva a utilizzare i segretari regionali come pasdaran del rinnovamento.
Ricordo che alcuni dirigenti locali (tra questi, in primis, il mio amico Francesco Ghirelli, segretario in Umbria) erano soliti intervenire con veemenza in apertura delle riunioni per imprimere l’andamento voluto al dibattito, sparando a palle incatenate contro i conservatorismi e le resistenze al cambiamento. Io ero parte di questa generale spinta al rinnovamento, anche se molto sospettoso della prima fase dell’occhettismo, che portò al famigerato XVIII congresso, quello del “nuovo Pci” tutto orientato a sinistra, ecologista, pacifista e anticraxiano, da cui uscii più sconfortato che mai, quasi deciso a mollare la segreteria in Basilicata (per fare che, mi dicevo, per restare senza un lavoro?). Fu il buon Piero Fassino a ridarmi qualche speranza. Aveva avuto da Occhetto l’incarico di sondare i dirigenti periferici sull’eventualità del cambio del nome, se non ricordo male erano i primi giorni di ottobre, mentre la DDR ribolliva di manifestazioni e proteste, da Lipsia a Berlino Est.
La telefonata che mi fece la ricordo come se fosse avvenuta ieri. Lui quasi non trovava le parole per affacciare l’ipotesi del Grande Cambio: “Claudio, ma che ne diresti se mettessimo in discussione un po’ tutto… anche il nome…”. Io gli risposi urlando nella cornetta, con tutta l’energia che avevo in corpo: “Piero, ma che cazzo aspettiamo? Ti rendi conto che ci sta crollando tutto addosso? E voi state ancora a perdere tempo… Sbrigatevi! Cambiamo tutto!!!”. E lui: “Va bene, ho capito, immaginavo, so come la pensi… ma tu come lo chiameresti il nuovo partito? Nel nome ci vorresti un richiamo alla socialdemocrazia, al mondo del lavoro? Dal simbolo toglieresti falce e martello?”. Io gli dissi, nella mia furia iconoclasta, che il simbolo andava buttato via senza indugi, ma insistetti per un solido ancoraggio alla socialdemocrazia nel nome. Lui prese atto, mi disse che c’era un’ampia maggioranza di segretari che pensavano fosse necessario sbrigarsi. Ma in realtà a Roma non si sbrigarono affatto. E bisognò aspettare il crollo del Muro il 9 novembre perché finalmente Occhetto andasse alla Bolognina e pronunciasse quelle parole liberatorie che tu hai citato. Anche se, in realtà, era chiaro che lui e i suoi giovani leoni si cagavano sotto, perché immaginavano e temevano le reazioni dei vecchi.
L’anno prima avevano concepito il putsch (odioso e sprezzante) nei confronti di Natta come un feroce cambio generazionale, ma erano certi che la base l’avrebbe assorbito tranquillamente, con lo spostamento a sinistra e l’antisocialismo, insomma con potenti iniezioni di “diversità”, la parola chiave che ricordi. Ma non avevano messo in conto il crollo dell’Est, di fronte al quale si trovarono del tutto impreparati. A quel punto non bastava più la loro paccottiglia movimentista. Avrebbero dovuto fare i conti con la storia. E non avevano le palle e la cultura per farlo. Non potevano scegliere l’approdo socialdemocratico, perché a quel punto sarebbero finiti nelle fauci di Napolitano, Macaluso, Lama, Chiaromonte, gente ben più temprata di loro. E così presero la strada, insipida e slavata, di un nome che non conteneva la parola “socialismo”, e di una variante furbetta del simbolo (che anche altri partiti avrebbero preso poi come esempio per cambiare senza cambiare) con la falce e il martello che resistevano alla base di una quercia che si stagliava vigorosa e rigogliosa. Anche se poi l’albero finì per produrre solo le ghiande di ordinanza.
© Riproduzione riservata