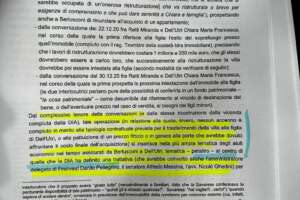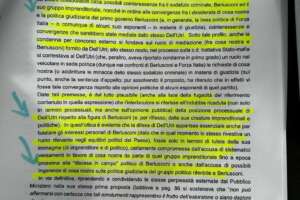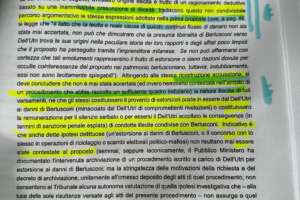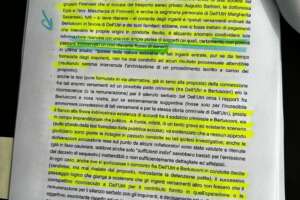L’inchiesta sulle stragi
I pm di Firenze contro Dell’Utri ma a Palermo smontano l’accusa: le prove non ci sono

A Firenze la giustizia sequestra dieci milioni a Marcello Dell’Utri e alla moglie perché costituivano entrate, provenienti da rimesse di Berlusconi, che il beneficiario non aveva comunicato come si deve, e cioè nei termini e secondo i protocolli che deve rispettare un condannato per mafia. Ma con un corollario accusatorio: vale a dire che ci sarebbe puzza che tutti quei soldi servissero a ripagare Dell’Utri per i servigi resi a Berlusconi, in buona sostanza coprirne le responsabilità mafiose. A Palermo, dove c’è un processo pressappoco sulla stessa minestra, le cose vanno diversamente.
Nel senso che l’accusa, che rimesta nello stesso pentolone, è zittita da una sentenza che prende quella pietanza e la giudica non commestibile. Vale la pena di occuparsene perché c’era un capolavoro di pregiudizio inquisitorio nelle pretese dell’accusa pubblica che a Palermo, prima del sequestro dei fondi di Marcello Dell’Utri disposto l’altro giorno dalla giustizia fiorentina, chiedeva altre misure restrittive a carico del vecchio collaboratore di Berlusconi. Un vero e proprio capolavoro. Tutti quei versamenti nelle tasche di Dell’Utri, spiegava l’accusa, dovevano per forza avere natura e finalità illecite perché (attenzione al garbuglio) il fatto che non ne fosse dimostrata l’illiceità non ne provava la liceità.
È un po’ noioso, ma vale la pena di trascrivere il passo eminente di quella ricostruzione inquisitoria (diciamo che Vyšinskij non ne sarebbe stato capace): “Il fatto che la lecita e reale causa di questo continuo flusso di denaro non sia mai stata accertata – diceva l’accusa – non può che dimostrare che la presunta liberalità di Berlusconi verso Dell’Utri trova le sue origini nella peculiare storia dei loro rapporti”. Tradotto: quei due facevano affari poco limpidi, ovvio quindi che non si trovino le prove. Poi l’argomento inoppugnabile: “Se non può affermarsi con certezza che tali emolumenti rappresentino il frutto di estorsione o siano dazioni dovute per occulte cointeressenze… tuttavia, indubbiamente, essi non sono lecitamente spiegabili”. E qui non serve nemmeno la traduzione, perché la teoria è chiara: siccome il reato deve esserci per forza, il fatto che non ci sia è inspiegabile.
Il tribunale, accantonandolo come merita, lo chiama sofficemente “non condivisibile percorso argomentativo”. E, ridicolizzandolo con una certa eleganza, lo liquida aggiungendo che la mancata prova del carattere illecito di quelle rimesse economiche da Berlusconi e Dell’Utri dovrebbe condurre alla conclusione che l’illecito non è provato perché non è provato: non alla conclusione che l’illecito è provato perché manca la prova che non è illecito. Ma la decisione palermitana è poi interessante perché fa giustizia di un altro assunto dell’accusa, vale a dire che quei soldi a Dell’Utri servissero a ottenerne le compiacenze e reticenze in sede processuale. Spiega infatti il tribunale che ragionevolmente e lecitamente Berlusconi avrebbe potuto avere interesse al buon esito della difesa di Dell’Utri, per l’ovvia considerazione che l’accertamento di eventuali responsabilità del suo collaboratore avrebbero determinato inevitabili e negativi effetti di discredito “della sua immagine di imprenditore e di politico”.
Che è come scoprire l’acqua calda, nel senso che se dicono che sei mafioso, e un’accusa di mafia lambisce un tuo strettissimo collaboratore, tu non fai proprio nulla di strepitosamente inaspettato se lo aiuti a difendersi. Ma non era così, evidentemente, per l’accusa, la quale ragionava in senso opposto e cioè nel senso che siccome sei mafioso è ovvio che aiuti con modalità mafiose il tuo sodale. E le prove, ancora una volta, lasciamole perdere: come esse non servono per dimostrare l’origine illecita di un finanziamento, infatti, così non servono per dimostrare l’esistenza dell’illecito che il finanziamento ripagherebbe. Si presume. Si deduce. Si ipotizza. E tanto basta, almeno fino alla decisione del giudice che dice che in un processo di diritto le cose funzionano, o almeno dovrebbero funzionare, diversamente.
E così si presume, si deduce e si ipotizza anche in merito all’estorsione che Dell’Utri avrebbe esercitato sul suo benefattore: dammi i soldi, sennò spiffero tutto. Ipotesi rispetto alla quale il tribunale, oltre alla noiosissima considerazione secondo cui l’ipotesi è del tutto sfornita di qualsiasi riscontro probatorio, oppone il grammo di buon senso per cui apparirebbe un po’ strano, poco verosimile, se non addirittura incredibile, che Berlusconi eseguisse quei pagamenti, frutto dell’estorsione, squadernandoli in faccia a un esercito di avvocati, consulenti, commercialisti, esponenti di partito, funzionari d’azienda, segretarie: tutta gente che, si è appreso, sapeva perfettamente di quelle regalìe e che chiunque, prudentemente, terrebbe all’oscuro di operazioni tanto losche e così facilmente denunciabili.
D’accordo la fedeltà assoluta dei collaboratori, specie se il padrone è un mafioso: ma, insomma, magari non fai sapere proprio a tutti che dai dei soldi a uno che minaccia di farti mandare al gabbio se non fai il bravo. Resta da vedere che cosa vale di più nell’altro processo, quello sulle prime pagine e nei talk show: se vale di più l’accusa sorretta dalle deduzioni, dalle presunzioni e dalle prove che non ci sono, o invece la sentenza che dice che, senza le prove, quelle deduzioni e quelle presunzioni non valgono nulla. E bisognerà vedere se, a Firenze, l’accusa riterrà di perseverare nel ripescaggio di elucubrazioni che un giudice già una volta ha considerato buone per un originale racconto, ma non per dichiarare la responsabilità di qualcuno in nome del popolo italiano.
© Riproduzione riservata