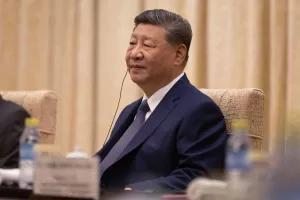Un luogo di riparazione
Carceri, investire su istruzione, lavoro, cura delle dipendenze e legami. Solo così si aiuta la società

«Una delle guardie che gli stava vicino dette uno schiaffo a Gesù … lui gli rispose: “…perché mi percuoti?”» (Gv 18, 22-23). Il Cristianesimo, — uno dei fondamenti dell’umanesimo europeo, — è l’unica grande religione in cui il fondatore è un laico che finisce arrestato, attraversa l’umiliazione della custodia, conosce tortura e violenza legale, e muore come condannato. La Croce è anche il riscatto di un’ingiustizia storica.
Dentro la modernità, la critica laica ai sistemi punitivi, che unisce Beccaria e Filangieri all’eredità socratica, ha insegnato a diffidare della vendetta pubblica e dell’arbitrio. Ma già la teologia morale di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori anticipava che la persona non si esaurisce nel suo delitto, e la pena, se vuole essere davvero giusta, non può ridursi a pura ritorsione. Quando ragiona delle censure, egli richiama esplicitamente la loro natura “terapeutica”: «censura enim est poena medicinalis… aliter sanari non potest», cioè una pena che mira a “sanare” la contumacia e a ricondurre il colpevole nell’ordine della convivenza (Theologia Moralis, lib. VII, cap. I, dub. IV, n. 53; Napoli: 1748). Non sorprende allora che, nel Giubileo dei detenuti, Leone XIV abbia scelto parole semplici e politicamente esplosive: «nessun essere umano coincide con ciò che ha fatto», e la giustizia, se vuole restare umana, è «riparazione e riconciliazione».
La speranza, qui, non è un sentimento privato: è categoria pubblica. Il Papa ricorda il gesto di Francesco a Rebibbia, e mette al centro la logica evangelica di un Dio che «non vuole che alcuno si perda» (2 Pt 3,9) e per cui «nulla è impossibile» (Lc 1,37). La letteratura russa, per esempio, aiuta a non mentire, ma anche a comprendere le profondità dell’anima. Nel Maestro e Margherita, Bulgakov mette in scena Pilato che nell’epilogo del romanzo conversa con Gesù dopo la morte. «Che supplizio triviale! Ma tu, ti prego, dimmi, (…) non c’è stato, il supplizio! Ti scongiuro, dimmi che non c’è stato. — Ma certo che non c’è stato, — risponde con voce roca il compagno, — ti è apparso soltanto». In quel paradosso di oblio si intravede una teologia apofatica della speranza. Dostoevskij, in antitesi dialettica, legò ancora prima speranza e memoria in maniera indissolubile, e nei Fratelli Karamazov Ivan restituisce addirittura il biglietto di entrata nel Paradiso per restare con la memoria delle ingiustizie. Il romanzo Delitto e castigo in russo suona più precisamente come “Il delitto e la pena” (Prestuplenie i nakazanie): il problema non è il castigo in sé, ma il senso della pena. La prima edizione italiana del 1889 (Treves), che traduceva la versione francese, fissò però l’uso di “castigo”, influenzando per sempre il titolo in italiano. Dostoevskij invece non poté fare a meno di trarre ispirazione dal celebre saggio di Cesare Beccaria Dei delitti e delle pene, che era stato tradotto e pubblicato in Russia già nel 1805. Dentro questa oscillazione lessicale c’è la domanda: pena come vendetta o come percorso?
E il principe Myškin nell’Idiota, parlando della pena di morte, inchioda la coscienza moderna: uccidere “per” un omicidio è una pena più grande del delitto stesso, perché toglie all’uomo persino il tempo del pentimento e della ricostruzione interiore. La dottrina cattolica, quando è fedele al Vangelo, non divinizza mai la pena: la orienta. Il Catechismo ricorda che la punizione deve riparare il disordine creato dal reato e, «per quanto possibile», favorire la correzione del colpevole, richia-mando persino il buon ladrone. E aggiunge che oggi i casi in cui l’eliminazione del reo sia «necessaria» sono «molto rari, se non praticamente inesistenti». In questo senso la modernità non fa altro che realizzare il monito del Vecchio Testamento sulle origini: «“chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!”. Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse» (Gen 4, 15).
La pena deve avere un fine, altrimenti diventa superstizione civile. Un carcere che investe su istruzione, lavoro, cura delle dipendenze, legami familiari, accompagnamento all’uscita e giustizia riparativa non sminuisce il reato: impedisce che il male si riproduca, e restituisce alle vittime non solo indignazione, ma sicurezza reale. È anche lo spirito dell’art. 27 della Costituzione: “rieducazione”, non vendetta. Tra memoria e speranza sta la misura di una comunità adulta: ri-cordare il male senza ridurre l’uomo al suo male, e proteggere la società senza perdere l’anima.
© Riproduzione riservata