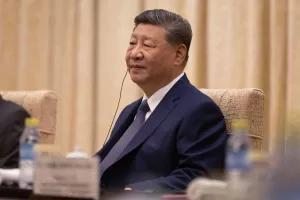PQM
I magistrati fanno fatica a concedere misure alternative. Se al reo viene negata una seconda occasione in società

Tutte le volte che i giornali e le tv diffondono la notizia di un delitto commesso con violenza da un detenuto in misura alternativa al carcere, un vortice irrazionale travolge la nostra società. In realtà, proprio in queste drammatiche occasioni, con la forza della ragione, bisogna difendere, rivendicandone l’allargamento, le misure alternative e le opportunità di lavoro all’esterno. Senza aggiungere l’ennesimo “chiodo sulla bara” ad un sistema di per sé già sgangherato. Se vogliamo dare forma ai princìpi costituzionali sulle pene e sul carcere, rendendo, così, più sicura la società, dobbiamo pretendere condizioni detentive rispettose della dignità umana. Solo attraverso uno sviluppo personale e sociale del reo possiamo favorire il suo reinserimento, rafforzando, così, la sicurezza collettiva. Lo avevano chiaro i costituenti nel 1948.
Sindrome da prisonizzazione
Lo aveva chiaro il legislatore del 1975, con la radicale sostituzione del regolamento fascista del 1931, disegnando apposite misure alternative alla detenzione nonché specifici obblighi di opportunità lavorative per i reclusi. Non si trattava di un mero sentimento di bontà, pur nella consapevolezza di dover ridurre il sovraccarico umano nelle celle. Era, piuttosto, una vera utilità sociale, dettata dalla esigenza di contrastare la c.d. sindrome da prisonizzazione, ovvero quel processo di immedesimazione disumanizzante nella vita in prigione, nonché la ghettizzazione nella società civile, fattori determinanti per la replica di condotte criminali una volta fuori dal carcere.
Difficoltà della magistratura
Purtroppo, a distanza di 50 anni dalla loro introduzione, dobbiamo riconoscere come l’effetto deflattivo delle misure alternative sia stato del tutto annullato dalla fabbrica di nuovi reati delle diverse compagini alternatesi al governo, dall’inasprimento delle pene e dalla schizofrenica estensione delle ostatività, in ragione di contingenti pulsioni. Si riscontra, inoltre, una evidente difficoltà della magistratura nella concessione delle misure alternative, condizionata, oltre che da insufficienti risorse umane, dalla violenza della pubblica opinione appositamente orientata da una politica irresponsabile e dai media sempre più aggressivi.
A fronte di circa 43.000 nuovi ingressi in carcere (04/24 – 04/25), i detenuti usciti nello stesso periodo in misura sono poco più di 19.000. Ancora oggi, in carcere vi sono 20.000 detenuti con pena residua fino a 3 anni, possibili fruitori, quindi, di percorsi di reinserimento sociale. Esiste un dato, però, che dovrebbe indurci a rivendicare l’incremento delle misure alternative al carcere e delle opportunità di lavoro, soprattutto all’esterno, difendendole da ogni attacco: la significativa riduzione della recidiva. I pochi studi effettuati in Italia ci dicono come la ricaduta nel reato di coloro che si trovano in carcere “sino all’ultimo giorno” sia pari al 70%. Le revoche delle misure alternative per la commissione di nuovi reati sono, in media, addirittura pari a 0,19%. Anche il cedimento alle lusinghe criminali, al termine della misura o di concrete opportunità lavorative all’esterno, si riduce drasticamente (una forbice che oscilla tra il 2% per gli occupati e il 19% tra gli affidati).
Oggi, purtroppo, oltre alle drammatiche condizioni di sovraffollamento dei nostri istituti di pena, siamo costretti a registrare una palese carenza di opportunità lavorative, specie all’esterno, per i reclusi. Secondo l’ultima relazione ministeriale, solo il 32% dei detenuti lavora, per la quasi totalità all’interno delle carceri, in attività per nulla formative o poco professionalizzanti. Solo il 5% lavora all’esterno, alle dipendenze di cooperative (4%) e aziende private (1%). Anche sul piano economico-finanziario converrebbe l’ampliamento dei percorsi risocializzanti. Si calcola che la mancanza di opportunità lavorative per i detenuti priva lo Stato di un ritorno sul Pil fino a 480 milioni di euro l’anno.
Il sistema che incide sul bilancio pubblico
Ancora, il sistema delle misure alternative alla detenzione incide, sul bilancio pubblico, meno di un decimo rispetto a quello carcerario. Siamo, però, prigionieri di un sistema gravato da una cronica inadeguatezza delle risorse destinate al trattamento, alla individuazione di percorsi individuali. Troppo orientato a scandagliare spericolate introspettive di colpa, piuttosto che a verificarne la tenuta comportamentale e relazionale.
La responsabilità di vanificare l’effetto benefico
Ci assumiamo, così, la responsabilità di vanificare l’effetto benefico, già sperimentato in diverse nazioni, prodotto, sulla sicurezza dei cittadini, da una pena detentiva dal volto umano, avviata lungo concreti ed effettivi percorsi di risocializzazione. Eppure, se solo informassimo correttamente la pubblica opinione, con dati del tutto inoppugnabili, sulla utilità del reinserimento sociale, pur graduale, del reo, potremmo riscontrare un consenso diffuso tra la popolazione, come dimostrato in Francia, alcuni anni fa, dai sondaggi condotti nell’ambito di uno studio su “Les mesures alternatives” e la loro efficacia nel contrasto alla recidiva.
© Riproduzione riservata