Letture
Quando la poesia argina l’orrore, la grande lezione di Paul Valéry
Il suo Corso di poetica è una miniera di filosofia e letteratura, di etica e poesia. Presente anche un omaggio squisito a Voltaire, che continua a parlarci ancora oggi
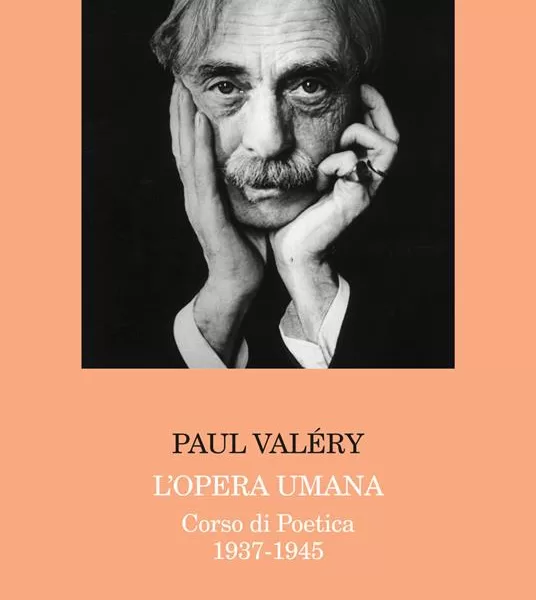
«Ieri sera – mentre qui non si sentivano che i colpi di cannone, le raffiche delle mitragliatrici e il crepitio degli incendi verso Neuilly, una voce divina dell’Opera di Berlino cantava non so quale musica, italiana – melodia la cui grazia e purezza si distaccavano come un fiore sul fondo di disordine, di violenza e di imbecillità…»: così scriveva il 25 agosto 1944 nei famosi Quaderni Paul Valéry, uno dei giganti del pensiero del Novecento, da noi un po’ (un po’ molto) trascurato. Benissimo dunque che Gramma Feltrinelli abbia da poco pubblicato “L’opera umana – Corso di poetica 1937-1945” a cura (molto preziosa) di Maria Teresa Giaveri e Paola Cattani.
Valéry tenne il Corso per otto anni al Collège de France nella fase prebellica e poi durante la guerra, e forse la grande riflessione sulla poesia, intesa nel suo “farsi” materiale, storico, fu per lui un grande rifugio spirituale. Il “Corso” di Valéry è una miniera di filosofia e letteratura, di etica e poesia davanti alla quale il lettore dei nostri giorni prova come uno sgomento per la profondità del pensiero e la – chiamiamola così – inestricabilità dei nessi che il pensatore francese stabilisce tra arte, storia e appunto filosofia. Le lezioni valériane non hanno un ordine del giorno preciso e delimitato. Valéry va come “a braccio”, seguendo sempre un itinerario intellettuale di altissimo livello, cercando il significato della “poetica” – dice in una delle ultime lezioni a mo’ di consuntivo – «ossia lo studio della fabbricazione di tutte le opere dello spirito (…) di tutte quelle opere che presentano un carattere di necessità derivato dai bisogni umani e di conseguenza di utilità», cioè addirittura «un imperativo fisiologico». Il tutto identifica «la possibilità di un’opera da collocare accanto alla Divina Commedia e alla Commedia umana, che rappresenterebbe la commedia delle cose dello spirito, la commedia intellettuale».
Di questa opera clamorosa e non conclusa, Valéry dissemina innumerevoli frammenti nei Quaderni (editi da Adelphi) e nel Corso di cui stiamo parlando, frammenti che in quanto tali non possono che costituire una tavolozza di colori diversi e contrastanti, irriducibili a uno solo. Anche di qui la difficoltà di andare al punto della lunga dissertazione del Corso, di estrarne il succo: operazione che probabilmente non va neppure tentata, stando lontano da organicismi che davvero mal si adattano alla complessità del pensatore francese. Non a caso Valéry, pur amato e preso a riferimento da intellettuali come Roland Barthes, Merleau-Ponty e tanti altri, non fonda una “corrente” ma resta un unicum nella storia del pensiero novecentesco. E non risulta agevole dunque fissare con categorie secche la posizione ideologica di Valéry.
Osserva Cattani nell’introduzione che egli «raccoglie la sfida all’aggiornamento della concezione umanistica dell’uomo e del mondo, che ritiene indispensabile e preziosa anche per apporre argini etici e culturali alla mentalità totalitaria»: ecco il senso della frase citata all’inizio con la contrapposizione tra «l’imbecillità» della guerra e la bellezza di quella musica italiana che udiva cantare. «In questo senso – si spiega nell’introduzione – il suo antimodernismo identifica non una forma di conservatorismo bensì un posizionamento antitetico al modernismo reazionario delle destre radicali» che, non dimentichiamolo, in quel frangente, fine anni Trenta, è egemone.
Diciamo che Valéry fu in un senso moderno un grande illuminista, che della ricerca fece il suo assillo e della modestia l’abito, e la sua lezione su Voltaire contenuta in questo volume resta come un punto fermo: «È stato ciò che potremmo chiamare un agente di accelerazione della modernizzazione del mondo, un intellettuale, un agente di transizione e di modernizzazione», anche facendo «accedere una gran quantità di individui a una vita intellettuale di un qualche valore». Ed è un omaggio squisito a quel filosofo che ancora ci parla, come ci parla Paul Valéry.
© Riproduzione riservata





