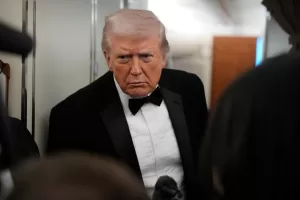Politica
Disoccupazione e inattività ai minimi storici ma gli stipendi restano al palo e le pensioni pesano (33% della retribuzione)

L’Ocse non perde occasione per segnalare l’esistenza di una questione salariale in Italia, fornendo alle organizzazioni sindacali e alle forze di opposizione argomenti per rintuzzare i dati positivi vantati da governo e maggioranza in altri campi. Anche nei giorni scorsi l’Organizzazione dei paesi industrializzati ha riconosciuto, all’Italia, l’aumento dei livelli di occupazione – con tassi di disoccupazione e inattività ai minimi storici, ed ha pure ammesso che nell’ultimo anno “il rinnovo dei principali contratti collettivi ha portato ad aumenti salariali negoziati superiori al solito’’; tuttavia, all’inizio del 2025 i salari reali erano ancora inferiori del 7,5% rispetto a inizio 2021 perchè gli aumenti non sono riusciti a compensare completamente la perdita di potere d’acquisto dovuta all’impennata dell’inflazione”.
Non sono all’orizzonte, in una breve prospettiva, segnali di robusto cambiamento, giacché “nel complesso – sostiene l’Ocse – la crescita dei salari reali rimarrà contenuta nei prossimi due anni. Si prevede, infatti, che i salari nominali in Italia aumenteranno del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026 a fronte di una inflazione del 2,2% nel 2025 e dell’1,8% nel 2026”. Dal canto suo Eurostat ha messo in relazione il livello dei salari e gli indici di povertà. “In Italia più di 1 lavoratore su 10 tra i 18 e 64 anni, occupati per almeno la metà dell’anno sia full time sia part time, è a rischio povertà”. Si tratta, dice Eurostat, del 9% dei lavoratori, in aumento rispetto all’8,7% del 2023, contro il 6,5% della Germania, il 9,3% della Polonia, il 2,8% della Finlandia e dei Paesi Scandinavi, in genere, e dell’11,3% della Spagna. A quest’ultima rilevazione ha risposto Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali, facendo notare taluni aspetti che solitamente sfuggono nel dibattito. Nel caso delle paghe contrattuali –ha sottolineato Brambilla- Eurostat non considera il TFR, che vale il 6,91% della retribuzione, oltre a un ulteriore 0,5% versato all’INPS per la tutela del lavoratore nei casi di fallimento dell’impresa. Già con questo 7,41%, l’Italia risalirebbe la classifica.
Poi Eurostat – ha ricordato Brambilla – non considera i contributi sociali a carico del datore di lavoro che, in Italia sono i più alti dell’area OCSE di almeno 6/8 punti percentuali. In sostanza, Brambilla mette il dito nella piaga: il cuneo fiscale e contributivo ovvero il rapporto tra il costo del lavoro per il datore e il salario netto in busta paga, evidenziando in particolare il peso preponderante degli oneri pensionistici (il 33% della retribuzione). Ma le segnalazioni dell’Ocse vengono ignorate quando affrontano – come ha fatto anche nel report dei giorni scorsi – il tema delle pensioni. In proposito, l’Ocse invita a prolungare la durata della vita lavorativa: una misura ritenuta necessaria non solo a “sbloccare risorse di manodopera”, ma soprattutto ad alleggerire l’onere delle pensioni che grava sulle generazioni più giovani, che devono affrontare le sfide economiche dell’invecchiamento demografico mentre, appunto, riscontrano un rallentamento nella crescita del proprio reddito. Tra il 2023 e il 2060 la popolazione in età lavorativa in Italia diminuirà del 34% e il numero di anziani a carico di ogni persona, in età lavorativa, aumenterà. Nello stesso periodo il rapporto tra occupati e popolazione totale diminuirà di 5,1 punti percentuali. Per far fronte a questa situazione, secondo l’Ocse: «Le politiche del lavoro devono evolvere per aiutare i lavoratori a rimanere più a lungo nel mondo del lavoro».
Va riconosciuto al governo Meloni di aver invertito nelle leggi di bilancio l’andazzo funesto di favorire l’anticipo del pensionamento. Ci troviamo però ad un passaggio delicato. Se il meccanismo dell’adeguamento automatico dei requisiti del pensionamento all’incremento dell’attesa di vita – appena ripristinato all’inizio di quest’anno dopo anni di blocco giallo/verde a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e un anno in meno per le donne a prescindere dall’età anagrafica – venisse manipolato o addirittura abolito, si aprirebbe una via crucis, secondo stime dell’Inps, di qualche miliardo di maggiore spesa e soprattutto verrebbe a mancare una importante condizione di sostenibilità. Peraltro nel 2025/2026 non risultano le condizioni demografiche per applicare il meccanismo, che invece ci sarebbero nel biennio successivo, in un limite ex lege non superiore a tre mesi. È necessario che il meccanismo di adeguamento automatico resti in vigore almeno per il trattamento di anzianità perché le generazioni del baby boom, per le loro storie lavorative, sono in grado, specie se uomini, di far valere questo requisito ad un’età media alla decorrenza della pensione inferiore a 62 anni.
© Riproduzione riservata