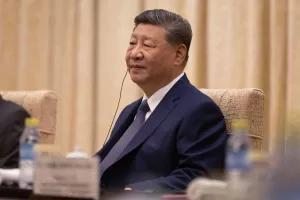Esteri
Trump usa la forza come leva negoziale e presenta la de-escalation come vittoria

Trump ha fermato l’attacco all’Iran in pieno tempo di recupero. Ma non perché intimorito dalle conseguenze o improvvisamente convertito alla moderazione. Ha fermato l’attacco perché ritiene che, in questo momento, la minaccia produca più risultati dell’azione. È una logica che il Presidente americano conosce bene e che ha già applicato in passato: spingere il sistema sull’orlo dell’escalation per poi arretrare di mezzo passo, rivendicando il controllo degli eventi. Non è esitazione, è una strategia di pressione calibrata, in cui la forza serve soprattutto come argomento negoziale.
La sequenza dovrebbe ormai essere chiara. Dichiarazioni pubbliche aggressive, posture militari visibili, messaggi pensati per essere letti a Teheran ma anche nelle Capitali alleate. Poi, improvvisamente, la sospensione. Non come ammissione di errore, ma come conseguenza di “nuove informazioni”, di segnali ricevuti, di una presunta riduzione della repressione interna iraniana. È il classico meccanismo trumpiano che consente di presentare la de-escalation come una vittoria: abbiamo minacciato, qualcosa si è mosso, quindi possiamo fermarci. La guerra resta sul tavolo, ma non viene giocata.
In questo quadro, il peso degli attori regionali è stato forse decisivo. Arabia Saudita e Qatar, insieme ad altri Paesi del Golfo, hanno segnalato con estrema chiarezza che un attacco americano avrebbe avuto un effetto detonatore sull’intero Medio Oriente. Basi esposte, infrastrutture energetiche vulnerabili, rotte marittime a rischio e la quasi certezza di una risposta iraniana indiretta ma diffusa. Per Stati che hanno investito anni nel ridurre la tensione con Teheran, una guerra “preventiva” americana sarebbe stata un ritorno al caos. Trump ascolta poco la diplomazia tradizionale, ma ascolta molto chi può trasformare una crisi regionale in un problema economico globale.
Non si tratta nemmeno, come spesso si suggerisce, di frizioni tra Casa Bianca e Pentagono. Piuttosto, anche in questo caso, di una dinamica ormai nota: i militari mettono in fila i costi reali dell’escalation, la politica usa la minaccia per ottenere leva. Il risultato non è paralisi, ma una divisione del lavoro implicita. La Casa Bianca alza il tono, il Pentagono frena sull’esecuzione. Quando l’arretramento arriva, può essere raccontato come prudenza strategica, non come debolezza. In questo spazio si inseriscono figure informali e canali laterali. Il nome di Witkoff circola tra i probabili responsabili del cambio di rotta. La diplomazia, in questa fase, non passa solo dalle ambasciate ma da rapporti personali, contatti indiretti, segnali lasciati filtrare ad arte. È un metodo che riduce i costi politici interni e mantiene la massima ambiguità strategica.
Sul piano simbolico, pesa infine anche il ritorno sulla scena di Reza Pahlavi. Il suo discorso di ieri ha rilanciato l’idea di un’alternativa reale e imminente al regime, insistendo sulla distinzione tra l’Iran come nazione e la Repubblica islamica come apparato di potere. Per Washington è una narrativa utile: permette di esercitare pressione senza apparire come promotori di un cambio di regime imposto dall’esterno. Ma è una lama a doppio taglio. Ogni riferimento a un’opzione post-teocratica rafforza il messaggio verso la diaspora e l’opposizione, mentre offre al regime l’ennesimo pretesto per irrigidirsi in nome della minaccia straniera.
Trump, in definitiva, non minaccia e poi ritira la mano per incoerenza. Lo fa perché il suo obiettivo non è la guerra con l’Iran, ma il controllo del ritmo della crisi che porterà inevitabilmente al crollo del regime. Tenere Teheran sotto pressione, rassicurare gli alleati più esposti, evitare un’escalation che nessuno nella regione desidera davvero e, soprattutto, dimostrare di essere l’unico in grado di accendere e spegnere l’interruttore. In Medio Oriente, oggi, non è una strategia elegante. Ma è forse una strategia più deliberata di quanto si creda.
© Riproduzione riservata