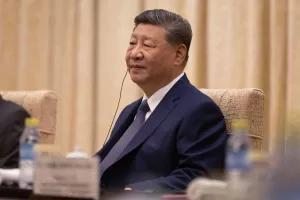Entrambe ignorano la lotta agli ayatollah
Albanese e Salis allergiche all’Occidente, il silenzio sulla rivolta in Iran e le battaglie che si fanno solo contro Israele
La relatrice Onu e l’europarlamentare di Avs hanno condotto una feroce campagna contro Israele. Ma si sono scoperte timide sulle proteste del popolo iraniano perché non sono anti-occidentali

C’è un filo rosso che lega Francesca Albanese e Ilaria Salis. È un allineamento ideologico profondo, che non si limita alla critica di Israele, ma costruisce una narrazione sistematica in cui la violenza anti-israeliana viene normalizzata, giustificata e infine nobilitata; mentre altre forme di oppressione, che dovrebbero essere condannate, vengono accuratamente rimosse. Una narrazione che non è solo sbagliata o parziale, ma pericolosa.
Nel caso di Ilaria Salis, l’elemento più inquietante emerge nella difesa pubblica del palestinese Anan Yaeesh, arrestato a L’Aquila con l’accusa di terrorismo. Salis non si limita a chiedere garanzie procedurali o a invocare prudenza giudiziaria. Va oltre: afferma esplicitamente che ciò che per lo Stato italiano, per l’ordinamento democratico e per la Comunità europea costituisce terrorismo, per lei è invece “resistenza al colonialismo”. Una resistenza che, in quanto tale, non solo sarebbe legittima, ma addirittura degna di ammirazione e sostegno. Il parallelismo azzardato con la Resistenza partigiana durante la Seconda guerra mondiale completa l’operazione retorica: Yaeesh non sarebbe un soggetto da processare, ma una figura da riabilitare e portare a simbolo.
Qui il salto di qualità è evidente. Non siamo più nel terreno della critica politica o della solidarietà ideologica, ma nella riscrittura dei concetti fondamentali di violenza, terrorismo e legalità. Se l’uso deliberato della violenza contro civili può essere ridefinito come “resistenza” in base al contesto geopolitico e all’identità del bersaglio, allora salta ogni distinzione giuridica e morale. È una logica che scivola pericolosamente verso la legittimazione della violenza politica, purché diretta contro il “nemico giusto”.
Parallelamente, Francesca Albanese, nel suo ruolo di relatrice Onu, conduce un attacco frontale a ogni tentativo istituzionale di contrasto all’antisemitismo. La recente iniziativa parlamentare volta a definire una legge concertata contro l’odio antiebraico viene da lei descritta non come uno strumento di tutela, ma come un favore allo “Stato coloniale” israeliano e all’“apartheid” che, secondo la sua lettura, Israele eserciterebbe nei confronti dei palestinesi. Anche qui, il meccanismo è lo stesso: l’antisemitismo non è più un problema autonomo da combattere, ma diventa sospetto, implicitamente illegittimo, se non si allinea alla narrazione anti-israeliana.
Il punto decisivo, che lega indissolubilmente le due donne, è ciò che entrambe omettono. Il silenzio sull’Iran è assordante. Nessuna indignazione proporzionata per il popolo persiano massacrato dagli ayatollah, per le donne uccise, per i manifestanti accecati, incarcerati, impiccati. Evidentemente, nella gerarchia morale di questa narrazione, gli iraniani non sono “resistenti”. O, quantomeno, non lo sono verso il nemico giusto. La loro rivolta non è spendibile, perché coincide – per un tragico paradosso – con l’interesse strategico dell’Occidente. E questo basta a rendere necessario nasconderla.
È qui che la narrazione diventa non solo ipocrita, ma eversiva nel senso culturale del termine: sovverte i criteri stessi con cui una democrazia distingue tra violenza e dissenso, tra terrorismo e resistenza, tra tutela dei diritti e propaganda ideologica. Quando tutto ciò che colpisce Israele è giustificabile mentre tutto ciò che smaschera altri regimi, purché anti-occidentali, viene ignorato, non siamo più davanti a una battaglia per i diritti umani, ma a un’ideologia che seleziona vittime e carnefici in base all’odio per l’Occidente. Ed è proprio questa selettività, lucida e consapevole, a rendere la narrazione di Albanese e Salis non solo sbagliata, ma pericolosa.
© Riproduzione riservata