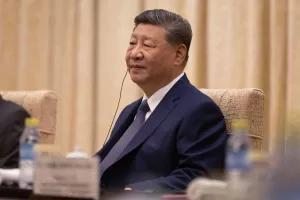Groenlandia
Groenlandia, l’Unione Europea non può considerare l’Artico periferia

Ridurre la questione Groenlandia a una nuova bizzarria di Donald Trump è una scorciatoia comoda, ma profondamente fuorviante. Il problema non è lo stile, che resta quello di sempre, muscolare, transazionale, volutamente provocatorio. Il problema è che dietro quella forma c’è una sostanza che l’Europa continua ostinatamente a non voler guardare in faccia. L’Artico non è più un confine remoto della politica internazionale, un vuoto bianco buono per i dossier ambientali e per i comunicati multilaterali. È diventato uno spazio centrale di competizione strategica, dove sicurezza, economia e tecnologia si sovrappongono.
Il cambiamento climatico, paradossalmente, ha restituito centralità geopolitica a una regione che per decenni era rimasta ai margini. Rotte marittime più brevi, accesso a risorse energetiche e minerarie, possibilità di controllo e sorveglianza su aree cruciali del Nord Atlantico: l’Artico è tornato a essere una scacchiera. In questo contesto, la Groenlandia non è tanto una terra da “possedere” quanto un’infrastruttura strategica: radar, basi, capacità di early warning, controllo dei flussi tra oceani. È un moltiplicatore di potere, non un oggetto simbolico.
La reazione europea, invece, rivela una fragilità strutturale. Per anni l’Artico è stato trattato come una questione settoriale, affidata a esperti e diplomazie tecniche, mentre la dimensione di sicurezza veniva di fatto esternalizzata agli Stati Uniti e alla NATO. Nessuna vera strategia continentale, nessuna visione integrata su infrastrutture, presenza militare, autonomia tecnologica, materie prime critiche. Così, quando Washington decide di rimettere il tema al centro dell’agenda, anche in modo brutale, l’Europa scopre di non avere una posizione propria, se non l’indignazione di principio.
Il punto più scomodo è che questa inerzia europea si svolge mentre altri attori si muovono con estrema lucidità. La Russia considera l’Artico parte integrante della propria architettura di sicurezza e agisce di conseguenza. La Cina, pur non essendo una potenza artica, investe, pianifica e costruisce una presenza a lungo termine. L’Unione Europea, invece, resta intrappolata nella dialettica interna: Berlino moralizza, Parigi fa l’isterica, Roma si smarca, Bruxelles tenta di ricomporre, ma il risultato è una voce debole su un dossier che richiederebbe decisioni dure.
Alla fine, quindi, la questione non è se Trump stia forzando i limiti del linguaggio diplomatico. Lo fa da sempre. La questione è perché l’Europa abbia permesso che un tema strategico di questa portata emergesse solo come reazione a una pressione esterna. La Groenlandia non è un incidente, è un segnale. L’Artico è già un teatro centrale della competizione globale e chi continua a considerarlo una periferia scoprirà troppo tardi di aver rinunciato a giocare la partita. In questo senso, più che Trump, è l’Europa a doversi interrogare sul proprio ritardo cronico.
© Riproduzione riservata