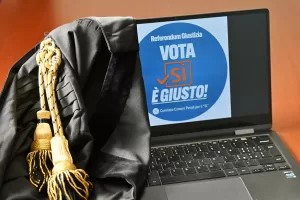Ambiente
Autonomia energetica USA, i conti non tornano. La colpa è delle raffinerie
Le infrastrutture americane sono dimensionate per lavorare greggi pesanti (come quello venezuelano) ma non lo shale oil prodotto in Texas, che Washington è costretta a esportare

Il petrolio venezuelano è al centro di un complesso intreccio di fattori industriali, geopolitici e strategici. Caracas dispone delle più grandi riserve di greggio al mondo – circa 303 miliardi di barili – gran parte dei quali classificati come heavy o extra-heavy, greggio denso e ad alto contenuto di zolfo, difficile da estrarre e trattare rispetto ai lotti leggeri della shale americana.
Negli anni precedenti alle sanzioni, questi volumi servivano regolarmente il mercato statunitense, in particolare le raffinerie della Gulf Coast attrezzate per processare greggi pesanti. Tuttavia, l’imposizione di sanzioni a PDVSA nel 2019 ne ha interrotto quasi completamente i flussi verso gli Stati Uniti, dirottandoli verso la Cina. Con la drastica riduzione della produzione – da oltre 3,5 milioni di barili al giorno negli anni ’70 a meno di 1 milione nel 2025 – e l’embargo, la presenza di Caracas nei mercati energetici globali è diventata simbolo delle contraddizioni tra enorme potenziale e reale capacità produttiva. Ma ha messo nei guai anche Washington.
Infatti, l’autosufficienza energetica USA sta in piedi solo se misurata in barili complessivi. Ma, pur disponendo di raffinerie dimensionate per raffinare greggi pesanti, può produrre solo greggi leggeri, che deve esportare, importando, invece, greggi pesanti che può processare all’interno del Paese. Questa evidente fragilità industriale espone Washington alla volatilità dei prezzi energetici ma anche a potenziali ricatti da parte dei produttori e dei clienti esterni. Con la rimozione del presidente Maduro e l’avvio di negoziati per la vendita di greggio agli Stati Uniti, Washington e Caracas hanno negoziato un accordo di fornitura fino a 50 milioni di barili, con le prime spedizioni già in corso verso i terminali nei Caraibi. Queste manovre non rappresentano solo un ritorno commerciale, ma anche un atto di orientamento strategico della politica energetica statunitense, che mira a ricostruire la propria resilienza energetica e a ridisegnare le rotte di approvvigionamento nel continente.
Per gli operatori industriali statunitensi, il petrolio venezuelano offre vantaggi concreti: a differenza di quello canadese, venduto a sconti più profondi ma con una composizione meno adatta alle condizioni di mercato attuali, il greggio di Caracas – in particolare il Merey-16 – è proposto alle raffinerie americane a prezzi più competitivi e con un profilo di prodotto che prevede meno nafta, un componente di basso valore nella raffinazione. Le raffinerie complesse della Gulf Coast, dotate di impianti di coking e idrocracking, sono storicamente progettate per trattare proprio questi greggi pesanti e ad alto zolfo, convertendoli in prodotti di alto valore come diesel e carburanti per l’aviazione. Anche se la rivoluzione del cracking ha portato gli Stati Uniti a produrre grandi volumi di greggio leggero da shale, la capacità industriale di processare petrolio pesante è rimasta critica per ottimizzare i margini e bilanciare la filiera di raffinazione. Tuttavia, le opportunità non sono prive di limiti e rischi. Prima di tutto, la produzione reale del Venezuela è soggetta a vincoli strutturali: l’industria petrolifera nazionale ha sofferto anni di abbandono, corruzione, deterioramento delle infrastrutture e mancanza di manutenzione, con conseguente declino delle capacità estrattive. Anche con un aumento potenziale del 30% della produzione nel breve termine, come stima (spera) Chris Wright, il segretario all’Energia USA, l’impatto sui mercati globali resterebbe contenuto e graduale.
In questo quadro, le compagnie petrolifere internazionali – incluse alcune grandi statunitensi – seguono la vicenda con interesse, ma anche con prudenza. Le incertezze normative, i rischi legali connessi al cumulo di debiti e richieste di risarcimento da parte di imprese straniere (il Venezuela ha debiti per 150 Miliardi di dollari verso la Cina, ma anche verso grandi compagnie energetiche come ConocoPhilips per 12 miliardi, ed Eni per 3 miliardi) si sommano con la necessità di grandi investimenti per il ripristino della rete produttiva. La complessità si riflette anche sulle dinamiche geoeconomiche: la Cina – che ha assorbito gran parte delle esportazioni venezuelane negli ultimi anni – ha criticato le azioni di Trump, richiamando il principio della sovranità venezuelana sulle risorse naturali. Nel frattempo, trader come Vitol e Trafigura si sono mossi rapidamente per assicurarsi le prime forniture, precedendo talvolta i grandi gruppi petroliferi americani, segnando un possibile spostamento dei centri di gravità commerciale.
Dal punto di vista dell’equilibrio energetico globale, la reintroduzione di petrolio venezuelano permetterà di ampliare la gamma di greggi pesanti disponibili in un mercato che già vede un eccesso di offerta per il 2026, secondo le stime dell’Agenzia Internazionale per l’Energia. Tuttavia, è improbabile che questo si traduca in un abbassamento significativo dei prezzi al consumo, almeno nel breve periodo, dato l’attuale surplus di greggio e l’elasticità della domanda. Per l’Italia e l’Europa, che dipendono ancora in larga misura da approvvigionamenti energetici diversificati, questi sviluppi offrono spunti di riflessione sulla sostenibilità delle filiere energetiche e sulla necessità di strategie energetiche resilienti in un contesto globale in rapido mutamento.
© Riproduzione riservata