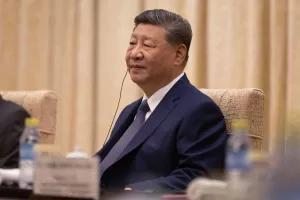Craxeide
Morte Bettino Craxi, i socialisti non hanno ancora elaborato il lutto. Un hombre vertical nel sistema che preferiva galleggiare

I socialisti non hanno ancora elaborato il lutto. Non hanno dimenticato il loro leader. A ventisei anni dalla morte di Bettino Craxi, avvenuta ad Hammamet, quel piccolo cimitero affacciato sul mare continua a essere meta di un pellegrinaggio silenzioso. Vi giungono italiani che non sono tutti socialisti; molti, anzi, non lo sono affatto. È il segno che il tempo sta riaprendo una riflessione più ampia sul politico, sullo statista, sul pensiero craxiano. Craxi fu un hombre vertical: per questo amato e, insieme, avversato. Come spesso accade, la storia si incarica di rimettere le cose nella giusta prospettiva. Sempre più italiani riconoscono in lui un patriota, con radici risorgimentali e una solida cultura dell’umanesimo socialista, che poneva al centro la persona, la dignità dell’uomo, i diritti e i doveri.
Il suo socialismo non fu mai dogma ideologico, ma progetto di emancipazione dentro la democrazia liberale, alternativa tanto al capitalismo selvaggio quanto ai regimi illiberali. In un’Italia bloccata da un bipartitismo imperfetto, prigioniera di equilibri consociativi e di una politica autoreferenziale, Craxi fu soprattutto un modernizzatore. Modernizzò il PSI, aprendolo alla società e formando una nuova classe dirigente; modernizzò l’azione di governo, introducendo decisionismo, responsabilità dell’esecutivo e centralità della leadership. Fu un innovatore politico in un sistema che preferiva galleggiare piuttosto che decidere. La sua battaglia per la Grande riforma nasceva da questa consapevolezza: senza riforme istituzionali la democrazia italiana sarebbe rimasta fragile e instabile. Rafforzare l’esecutivo, chiarire le responsabilità, superare la paralisi del parlamentarismo esasperato non significava tradire la Costituzione, ma renderla più aderente alla realtà. Quel progetto incontrò resistenze trasversali perché metteva in discussione rendite di posizione consolidate. Craxi pagò anche per questo: per aver tentato di cambiare le regole del gioco in un Paese che si guardava l’ombelico.
In politica estera fu un convinto occidentalista e un sostenitore del multilateralismo. Vide nell’Onu e nel diritto internazionale strumenti indispensabili per la stabilità globale e per ridurre il divario tra Nord e Sud del mondo. I suoi incarichi internazionali di fine anni Ottanta si collocarono in questa visione, così come il suo impegno per una soluzione negoziata del conflitto mediorientale fondata sul principio dei due popoli e dei due Stati. Sostenne il dissenso democratico contro le dittature e mantenne sempre una linea autonoma, spesso scomoda, rispetto alle grandi potenze. Anche sull’Europa fu lucido e anticipatore: ne colse il valore come spazio di pace, ma ne denunciò limiti e squilibri, rifiutando una narrazione acritica e subalterna. Oggi, mentre la damnatio memoriae che lo ha colpito si attenua, Craxi riemerge come ciò che fu realmente: un grande politico della Repubblica.
Pagò un prezzo personale e giudiziario altissimo, diventando il capro espiatorio di una crisi sistemica che travolse l’intera Prima Repubblica. Pagò per la sua irregolarità, per l’autonomia di pensiero, per non essersi allineato al deep State né all’establishment economico. Il craxismo non è una stagione archiviabile, ma un’attitudine politica: andare controvento, assumersi il rischio della decisione, pensare in grande quando il sistema invita alla rinuncia. La storia non assolve né condanna: misura le eredità. E oggi misura che Craxi, con tutte le sue contraddizioni, fu uno dei pochi leader capaci di immaginare un’Italia meno statica e più adulta. Per questo continua a dividere, ma soprattutto a interrogare il presente.
© Riproduzione riservata