Libri
Malempin, un ragazzino con la testa troppo grossa. Il misterioso senso di colpa di un uomo qualunque
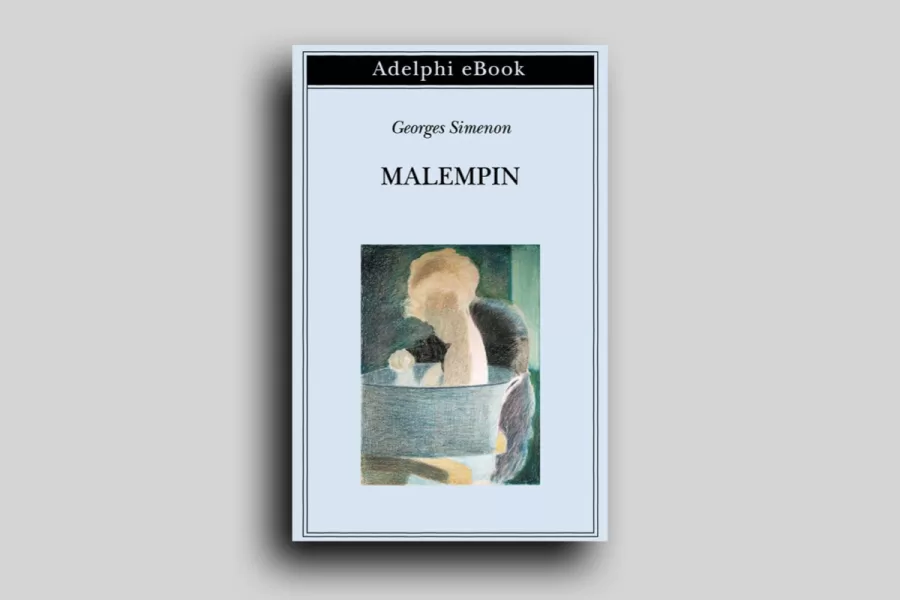
Questo ultimo Simenon –“Malempin” (Adelphi, traduzione di Francesco Tatò, pagg. 142) – appartiene alla prima produzione dello scrittore belga, essendo stato scritto nel 1939. Eppure è un romanzo su cui non è caduto un briciolo di polvere, per la qualità della scrittura e le mirabili descrizioni-non descrizioni di ambienti e personaggi.
Tutto qui è avvolto nella nebbia del passato, negli enigmi dei ricordi, ma anche nella inquietante ambiguità del presente: giacché Édouard Malempin, l’io narrante, mescola di continuo i due piani, passato e presente, fornendo un quadro d’insieme desolante e impenetrabile nel suo misterioso svolgersi. Ecco dunque il rimuginare – senza alcun costrutto – sulla sua infanzia trascorsa nella umida campagna dell’Aquitania in mezzo a un groviglio incomprensibile di sensazioni e di ambigui personaggi, a partire dal padre, dalla madre, dalla zia. E si tratta in un certo senso di quello stesso “groviglio di vipere” dell’omonimo romanzo di François Mauriac che si svolge non casualmente sempre in quella regione di Bordeaux, e “Malempin” in effetti sembra un libro di Mauriac, solo più moderno.
Brutta infanzia, dunque, quella del protagonista, un ragazzino con la testa troppo grossa, isolato, incompreso, inebetito dagli oscuri comportamenti dei familiari, che in testa, oltre a un costante rimescolio dei sensi, hanno una cosa sola: i soldi. Ma il presente, a Parigi, dietro il paravento dell’apparenza borghese, non è poi tanto meglio, e il segno di questa condizione è la malattia del figlioletto di Malempin, che paradossalmente è medico, quasi un’espiazione. Ma di che cosa? «Non ho mai cercato di sapere. Peggio! Non ho mai voluto sapere». Di cosa si tratti Simenon, secondo una sua magnifica caratteristica, lo dice e non lo dice. «Faccio tutto quel che posso. Sono dodici anni, che dico, venti, trent’anni che cammino in punta di piedi, che quasi non mi azzardo a respirare a pieni polmoni! Perché ho imparato che tutto è fragile, tutto quanto ci circonda, tutto quanto prendiamo per la realtà, per la vita: la fortuna, la religione, la quiete… E la salute, soprattutto!… E l’onestà…».
Parole che sembrano uscire da un deliquio di un personaggio di Dostoevskij – accade tante volte con le figure di Simenon – ripiegato su un destino incomprensibile. Certo, qualcosa di brutto il povero dottore deve aver fatto, qualche cosa che non ha detto. Insomma, è il senso di colpa che lo perseguita ma forse non si tratta di un fatto specifico: forse si tratta semplicemente dell’aver vissuto.
© Riproduzione riservata








