Riformista Cartaceo
Social media, qualche disturbo spezza un’egemonia senza regole: da Telegram a X, servirebbe responsabilità
Dal Telegram di Durov, un po’ troppo tollerante con alcune sacche di illegalità, al Twitter/X di Musk, oscurato in Brasile, e che a sua volta ha cacciato Trump: la Rete ha deflagrato incontrando la politica. Servirebbe un pizzico di responsabilità
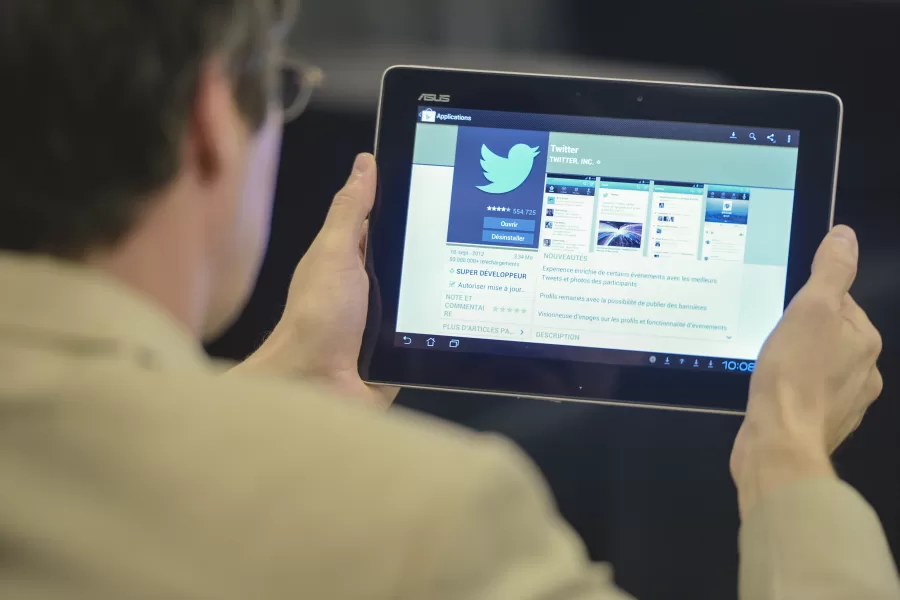
Negli ultimi giorni due eventi sembrano aver dischiuso la porta ad un piccolo disturbo, portato dall’egemonia assoluta dei social e dei loro profeti nelle nostre vite e nel mondo globale. Andiamo con ordine: il primo è il caso dell’inciampo giudiziario di Pavel Durov, il fondatore di Telegram, in Francia, suo paese – insieme ad altri due – di adozione. Le accuse sono molteplici: dodici capi d’imputazione che riguardano la sua piattaforma per la generosa ospitalità a pedopornografia, trafficanti di droga, furfanti dediti a frodi e a transazioni finanziarie infette, oltre a rappresentare la sanzione per il rifiuto di fornire agli inquirenti documenti e informazioni rilevanti per indagini giudiziarie.
Il quarantenne miliardario nato a San Pietroburgo, la città di Putin (con cui esiste un controverso rapporto che alterna vituperi ad abbracci), stimato tra i più ricchi del mondo, ha pagato la sua libertà con una cauzione di 5,5 milioni di euro vincolandosi all’obbligo di permanenza nel territorio francese. Nel frattempo una contestazione arriva a Telegram pure da Bruxelles, per aver violato la normativa della Ue. Il secondo evento ha per protagonista il solito Musk, patron di X, che si è visto “spegnere” il social dalla Corte Suprema Generale del Brasile di Lula. La motivazione è legata alla violazione della legge brasiliana che obbliga i social network operanti nel territorio nazionale ad indicare un legale rappresentante.
Decorso inutilmente un tempo per l’adempimento, Elon è stato “oscurato”. Non è che in passato non si fossero verificati conflitti tra decisori politici e social, causa efficiente di reazioni da parte dei capi di governo e dei capi di social. Clamorosa, nel 2020, la performance trumpiana con Twitter, il vecchio nome di X (all’epoca nelle mani di Dorsey). Trump, compulsivo frequentatore dei cinguettii che usava con il noto lievissimo ed elegante stile da camallo in libera uscita, un bel giorno lamentò d’essere oggetto di censure da parte della piattaforma. In effetti censura c’era stata per un tweet del presidente Usa che avrebbe violato, secondo i responsabili del social, gli standard relativi all’esaltazione della violenza in occasione di un commento sull’uccisione a Minneapolis dell’afroamericano Floyd da parte di un poliziotto. Lo stesso Trump, peraltro, aveva appena firmato un provvedimento che riguardava i social media operanti in territorio americano, togliendo loro le immunità sui contenuti ospitati dalle piattaforme. Insomma: un botta e risposta a stretto giro.
Allora, come adesso, si accese il dibattito sublime tra libertà assoluta e regole di convivenza che, ovviamente, non possono lasciare fuori dal bordo segmenti così significativi dell‘espressività umana. Un’aura di sacralità ha circonfuso, fin dalle origini, la Rete, un totem allegro fagocitatore di privatezza, trasformata in tracciato venduto secondo tariffario. Il che è grave di suo già quando si muove in ambito commerciale, ma diventa deflagrante quando si passa alla categoria della politica, dunque alla democrazia. Ma c’è di più: la cosa passa in cavalleria ormai senza un filo di pensiero applicato, ma qualche volta occorrerebbe riflettere che siamo tutti utenti di mezzi di proprietà privata. Lo siamo noi cittadini che chattiamo su Whatsapp con gli amici, la signora che fotografa le ricette culinarie su Facebook, sua figlia che studia le mise delle Kardashian su Instagram, ma anche i vertici della politica, delle istituzioni, delle religioni.
Che vuol dire? Vuol dire che possiamo “politicamente” concordare con l’insopportabilità etica dei turpiloqui di Trump, ma non possiamo assolutamente accettare la censura dal punto di vista del diritto di esprimersi che ha un capo di Stato, piaccia o no chi incarna quella carica. Eppure andrebbe già meglio se si applicassero ai social gli stessi criteri che oggi regolano l’attività d’informazione nei giornali e nelle televisioni e che rispondono essenzialmente ad un principio fondamentale: quello della responsabilità. Bisognerebbe essere tutti d’accordo, però, senza smagliature, senza isole alla Cayman che si offrano come paradisi d’impunità. L’Europa, bisogna riconoscerlo, è sembrata più attenta a questi temi. L’America meno. Ma forse oggi qualcosa si matura: qualche disturbo benigno alla condizione di “legibus solutis” delle piattaforme sembra annunciarlo.
© Riproduzione riservata








